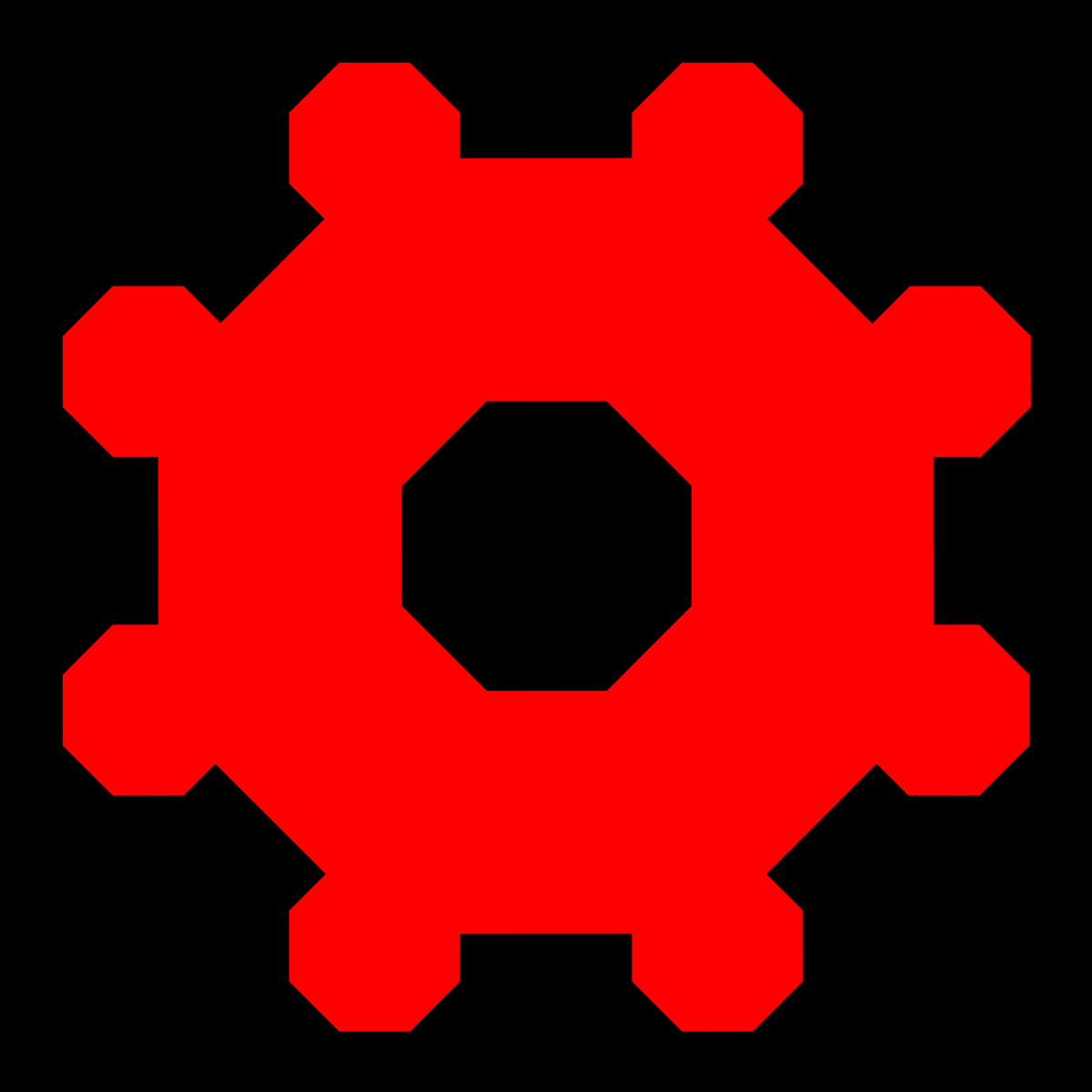Gli ulivi millenari sono i biglietti da visita di un luogo che “profuma” di storia e atmosfere suggestive

Cartoline da Carovigno
Carovigno, popoloso borgo in provincia di Brindisi a 5 km dal mare, offre un eccellente mix di storia, cultura, natura e tradizioni popolari. La sua Piana degli ulivi è ricca di “patriarchi verdi” dalle forme scultoree affascinanti. È possibile apprezzare questo grande patrimonio inoltrandoci in una rete di sentieri, tratturi e antiche strade, frantoi ipogei e suggestive grotte.
Nei giardini di Carovigno, il Parco Provinciale (a Nord) e il Parco Comunale, troviamo ulivi millenari, un piccolo viale botanico, essenze di macchia mediterranea. il Parco della rimembranza, dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale, e viali profumati con rose rampicanti.
L’araldica
Lo stemma di Carovigno, riconosciuto il 9 febbraio 1935, come tutti gli emblemi civici del Ventennio fascista era ornato dal fascio Littorio, eliminato dopo la caduta della dittatura. La forma attuale del gonfalone, un «drappo di color porpora, riccamente ornato di ricami d’oro e caricato dallo stemma, con l’iscrizione centrata in oro del nome del Comune» è tipica dell’araldica civica italiana, con stemma «D’azzurro, con un delfino cavalcato da un amorino che suona la cetra».
Le Torri e il Castello
Gli ingressi principali del centro storico di Carovigno sono costituiti dalle due antiche porte, Porta Brindisi e Porta Ostuni, e da due aperture più piccole, l’arco “del Prete” e la “Purticedda”. Della vecchia cinta muraria, spiccano quattro torri: la Torretta del civile, sulla quale si intravvede una meridiana; Torre Giranda e la sua stivatura, Torre “delli Brandi” (purtroppo inglobata in moderne costruzioni; la Torre circolare (del Prete). Ma l’attrazione principale del borgo è l’imponente castello Dentice di Frasso, le cui origini risalgono all’epoca normanna, con chiara vocazione difensiva (lo dimostrano la torre quadrata e gli ambienti sotterranei). A partire dalla fine del XIV secolo, il principe Raimondo del Balzo ampliò il castello e lo fortificò con una seconda torre, questa volta rotonda.

Nel 1492, il castello di Carovigno assunse la caratteristica forma triangolare con l’aggiunta della torre a mandorla ispirata ai progetti del celebre architetto militare Francesco Di Giorgio Martini. Le sue mura imponenti e la forma lanceolata ne fanno un originale esempio di adattamento delle fortificazioni medievali alle nuove strategie belliche. Nel 1791 il Castello entrò a far parte dei possedimenti dei Dentice di Frasso. L’ingresso è decorato con il motto della famiglia Dentice “Noli me tangere”, e il suo stemma nobiliare. All’interno, numerosi emblemi araldici – tra cui quelli delle famiglie Schlippenbach, Loffredo, Caputo, Granafei e Imperiali – raccontano il susseguirsi delle varie feudalità. Spiccano i grifoni a guardia della scalinata che conduce al piano nobile e diverse iscrizioni in latino incise all’interno delle sale. In un parco e in un orto botanico sperimentale, furono coltivate varietà di piante e frutti rari, grazie al contributo del celebre botanico dell’epoca Francesco Ingrosso.
Nel corso della storia, si sono avvicendati illustri visitatori, tra cui Guglielmo Marconi e il futuro re Umberto II. Nel 1961, il castello fu venduto da Luigi Dentice di Frasso all’Opera Maternità e Infanzia. Proprietà della provincia di Brindisi dal 1973, oggi in concessione al Comune di Carovigno, ospita la Biblioteca “ Morelli” e rappresenta, oltre che un patrimonio storico di inestimabile valore, un autentico punto di riferimento culturale e simbolico per l’intera Puglia.
Le Chiese
Nel borgo c’è da vedere la Chiesa Matrice, che risale al Trecento ed è dedicata all’Assunta. Della struttura cinquecentesca resta solo l’abside ed il bel rosone che un tempo si trovava sulla facciata principale. All’interno alcune tele settecentesche di artisti locali.
La Chiesa di S. Anna, vicino al Castello, fu costruita dalla famiglia Imperiali nel XVIII secolo. Tra le altre chiese da visitare ci sono la chiesa di Sant’Angelo (del Quattrocento) e la chiesa del Carmine, con affreschi del Settecento.
Il battimento della ‘Nzegna
Secondo una leggenda popolare, un pastore e un signore di Conversano, mentre contemporaneamente cercavano una giovenca smarrita e l’immagine della Madonna, le ritrovarono in una grotta della contrada di Belvedere a Carovigno. Il pastore e il signore (che fu miracolato), presi da emozione e gioia, per attirare l’attenzione dei contadini della contrada, legarono un fazzoletto colorato (‘Nzegna) al proprio bastone e cominciarono a lanciarlo in aria.

Ancora oggi, il “battimento della ‘Nzegna” viene riproposto durante la processione in onore della Vergine di Belvedere il lunedì, il martedì e il sabato dopo Pasqua.
Tre colpi di grancassa scandiscono i passi dei battitori che, avvolti nella ‘Nzegna, si portano verso il centro e danno inizio alla loro danza. Il suono del piffero li segue e li accompagna rimarcando con lunghe note squillanti, gli attimi in cui le bandiere vengono lanciate in aria ed i respiri degli spettatori si interrompono nell’attesa che i battitori le riprendano al volo prima che tocchino terra. E’ un rito propiziatorio, poiché l’eventuale caduta della ‘Nzegna sarebbe di cattivo auspicio per l’intera città.
Il rito si conclude con l’inchino finale e la deposizione della ‘Nzegna ai piedi della statua della Madonna. Il corteo quindi si ricompone per far rientro in cattedrale.
La ‘Nzegna è una bandiera composta da pezzi triangolari di stoffa multicolore, disposti ad incastro in doppia fila intorno ad un quadrato, all’interno del quale è raffigurato, con gli stessi colori dei triangoli, un fiore a dieci petali pentagonali, stilizzato: la rosa mistica, un simbolo mariano bizantino.
Recentemente il prof. Carito ha attribuito al drappo il significato di “pasquale segno di pace tra la comunità greca e quella di culturale latina“, collocando l’episodio della battitura della nzegna all’epoca della conquista della Puglia da parte dei normanni e alla complessiva ridefinizione dei rapporti coi cristiani di Bisanzio.
Negli ultimi secoli, Battitori della Nzegna sono stati i membri delle famiglie Brandi, Lanzillotti, Di Perna, Maellaro. Attualmente, ad assumere annualmente l’onere e l’onore della Battitura, sono due rappresentanti e discendenti delle famiglie di Sabino e Nicolò Carlucci che se la tramandano di padre in figlio da almeno quattro generazioni.
TORRE GUACETO
La Riserva naturale statale Torre Guaceto, situata sulla costa adriatica dell’alto Salento vicino a Carovigno, San Vito dei Normanni e Brindisi, si estende per 1.016 ettari a terra e 2.227 in mare. Presenta diversi habitat, dal litorale alle zone umide dovute a bonifiche e successivi allagamenti, ed è oggetto di studi scientifici, progetti di educazione ambientale e formazione professionale.

Gestita da un consorzio tra i Comuni e WWF Italia, la riserva è riconosciuta per il valore ambientale delle sue spiagge (premiate con Bandiera Blu) e per la sua biodiversità, che include 670 taxa di flora e numerose specie di fauna, come mammiferi notturni, uccelli e rettili. Tra gli uccelli che prediligono come dormitorio o punto di sosta il canneto di Torre Guaceto vi sono passeriformi come il pendolino e l’usignolo di fiume o uccelli di dimensioni maggiori come il porciglione, gli aironi e il tarabuso. Quest’ultimo, per mimetizzarsi al meglio tra le canne che lo circondano, può rimanere per molto tempo immobile in piedi o ondulare lentamente come canna al vento. Se viene disturbato, assume una particolare “posizione di attacco”. Altri protagonisti di quest’ambiente sono le rondini che in migliaia di esemplari vi stazionano durante i viaggi migratori. Tra i rapaci domina il falco di palude.
Recenti scavi hanno portato alla luce resti di un villaggio fortificato del Bronzo, mentre la scoperta, a partire dal 2019, di una necropoli a cremazione (con 35 tombe) ha evidenziato l’importanza storica del territorio, aprendo prospettive per la creazione di un museo archeologico.
teresa maria rauzino
su “L’Edicola” 14 aprile 2025