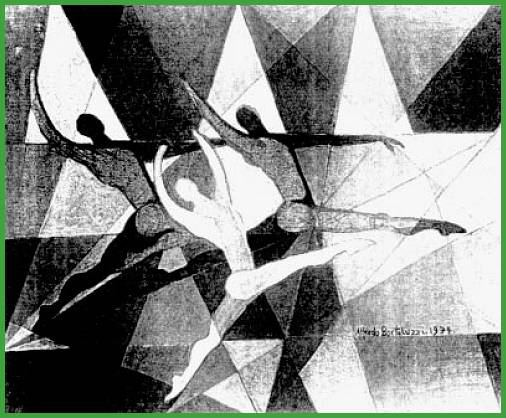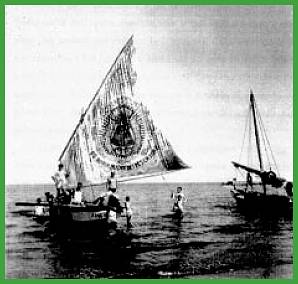Il Regio Istituto Tecnico “P. Giannone” fu istituito nell’anno 1885 per opera del cav. Antonio Cicella, membro del Consiglio Provinciale di Capitanata.
Egli presentò una proposta al Consiglio stesso affinché a Foggia fosse istituito un Istituto Tecnico che rendesse importante la città, tanto da poter essere paragonata a quelle più grandi d’Italia.
Prese parte alle trattative tra Comune, Provincia e Governo e, riunito il Consiglio Provinciale nella seduta del 2 dicembre 1884, riferì su quanto già operato fino allora favorendo lo stanziamento di somme occorrenti per il primo impianto della scuola da parte della Provincia; in quella tornata, il Consiglio Provinciale, dopo una lunga e travagliata discussione approvò l’ordine del giorno in cui si riaffermava il voto unanime emesso con delibera precedente il 31 maggio 1882 raccogliendo voti presso il Ministero della Pubblica Istruzione per l’istituzione del Regio Istituto.
Non fu semplice tuttavia impiantare l’Istituto stesso, poiché subito dopo la prima approvazione da parte del Consiglio Provinciale, sorsero i primi contrasti tra questo Ente ed il Comune di Foggia.
Già nella lettera del 31 luglio 1884, il Sindaco scrisse al Prefetto inviandogli la Delibera Consiliare del 24 maggio 1884, approvata dal Consiglio Provinciale Scolastico e dalla Deputazione Provinciale, con la preghiera di sottoporre la pratica al Consiglio Provinciale per il concorso delle spese previste dalla legge. Nella lettera anche il Sindaco evidenziava l’importanza dell’apertura di un altro istituto tecnico maggiormente specializzato e, pregava il Prefetto di sollecitare il Consiglio Provinciale Scolastico di porre al vaglio la questione per accelerare i tempi.
Inizialmente e con Delibera Comunale del 24 maggio 1884 era stato stabilito che l’Istituto fosse amministrativamente Governativo e che comprendesse tre sezioni: la prima ad indirizzo fisico-matematico, la seconda di agrimensura, la terza di ragioneria e commercio.
Era inoltre stato stabilito che per il pagamento del personale insegnante e direttivo, sarebbe stata stanziata la somma annua di L. 40.000 versata per metà a carico dello Stato e per metà a carico della Provincia; seguendo lo stesso criterio per il pagamento degli stipendi al personale non insegnante, al Segretario della Presidenza, agli ausiliari compresi gli assistenti ed i macchinisti, sarebbe stata stanziata la somma annua di L. 6.000.
Inoltre sarebbe stata a carico della Provincia la fornitura del materiale scientifico per i laboratori di fisica e chimica, per le macchine e gli strumenti topografici, per la collezione di materie prime e di prodotti industriali, per la biblioteca scolastica e quanto altro necessario al funzionamento della scuola, per un ammontare complessivo di L. 4.000 per le spese di primo impianto.
Sarebbe stata a carico del Municipio la disponibilità dei locali e degli arredi occorrenti alla scuola, e la Provincia per l’affitto dei locali avrebbe pagato una pigione annua da stabilirsi in seguito.
A tale riguardo si pensò prima ai locali del Monastero di S. Chiara, poi a quelli del Monastero dell’Annunziata che si presentavano ampi ed idonei allo scopo. Nel verbale si legge:
«[…] Il Consiglio Comunale esprime un caldo voto all’Amministrazione Provinciale perché voglia prendere in considerazione l’immenso beneficio che l’Istituzione non mancherebbe arrecare alla Provincia e voglia contribuire per la sua parte nelle previsioni di legge a far che l ‘Istituto Tecnico per la Provincia di Foggia possa al più presto essere fatto concreto».
A tal fine, si incaricava il Sindaco, Francesco Valentini Alvarez, di espletare tutte le ulteriori pratiche con il Governo e con l’Amministrazione Provinciale.
In seguito il Prefetto vista la Legge sull’Istruzione Pubblica n. 3295 del 13 novembre 1859, inviò agli enti il Decreto del 24 gennaio 1885 che gli era giunto dal Ministero della Pubblica Istruzione, con cui si approvava definitivamente a Foggia l’apertura di un Istituto Tecnico con i tre indirizzi scelti in precedenza.
Le motivazioni erano le seguenti: la sezione fisico-matematica avrebbe avuto carattere di scuola di cultura generale e, con l’indirizzo scientifico la scuola avrebbe eguagliato gli istituti umanistici per l’importanza delle materie insegnate. La sezione di agrimensura, avrebbe avuto tra gli insegnamenti gli elementi di geografia descrittiva, le costruzioni e la geometria pratica, infine la sezione di ragioneria e commercio avrebbe reso i giovani:
«[… ] provetti nel meccanismo degli scambi, nella conoscenza delle lingue straniere ed in tutti gli argomenti di economia politica applicata, di statistica, di geografia e di diritto, specie ora che il commercio ha tanta parte nella vita dei popoli e sono scomparse le dighe innalzate dai Governi assoluti per tener divise le nazioni[…]».
Fino allora la scuola tecnica già esistente, con sede presso l’Orfanotrofio M. Cristina, aveva dato solo un modesto completamento della scuola primaria sia per le materie di cultura generale sia per quelle tecniche; pertanto il nuovo Istituto per raggiungere i risultati sperati avrebbe dovuto assumere personale specializzato, ciò avrebbe reso migliore la qualità della scuola stessa ed avrebbe dato ai giovani l’occasione di istruirsi meglio raggiungendo così, gli obiettivi perseguiti.
I bisogni della Provincia erano tali da rendere indispensabile l’apertura del nuovo Istituto, che avrebbe formato gli allievi alla conoscenza delle tecniche più avanzate, garantendo nuovi posti di lavoro. A tale riguardo, il cav. Vincenzo Lacci, Segretario Capo dell’Amministrazione Provinciale nella sua relazione sull’impianto dell’Istituto scriveva:
«[…] La immensa utilità della Sezione di Commercio è vivamente dimostrata dai bisogni speciali della nostra Provincia, che forma un centro di progredite e molteplici transazioni commerciali;[..,] le sezioni di Agrimensura e Ragioneria torneranno praticamente assai utili ai nostri giovani; specialmente perché, promulgata la Legge sulla perequazione fondiaria, la misurazione scientifica del territorio italiano, […] daranno loro larghissimo lavoro pel non breve periodo di anni 20.[…] La Sezione di Agronomia, fornisce la teoria dell’arte agraria, cioè le nozioni tecniche generali dell’Agricoltura.[,..] La Capitanata racchiude una estensione di 350 mila ettari dì terre coltivate, e capaci dì coltura.[…] Ma una delle principali cagioni della decadenza dell ‘Agricoltura di Puglia -scriveva il nostro grande tecnologo foggiano Giuseppe Rosati – consiste nella ignoranza del mestiere, diffusa non solo nei contadini,[…] ma benanco nei proprietarii e generalmente in tutti gli altri che non si brigano di queste industrie… col mezzo più valevole, onde vincere questo difetto e far risorgere l’agricoltura nel suo pieno vigore è il sapere.[…] Per creare un ambiente favorevole alla propagazione dello stesso, non può procacciarsi, se non col magistero dell’Istituto Tecnico. […] L’Agricoltura italiana ha infiniti problemi, dei quali attende la soluzione. E noi […]per la vasta estensione del territorio di questa Provincia, abbiamo ben troppo bisogno di migliorarne, anzi di trasformarne la coltura. A conseguire tanto scopo, è d’uopo che i nostri giovani imparino anzi tempo a sciogliere tutt ‘i problemi che si riferiscono alla produzione del suolo, a conoscere il valore relativo dei concimi e le diverse proprietà dei terreni coltivabili, la composizione delle piante, […] ebbene lo studio tecnico fa molto di più per l’operaio ignorante, e per la varia e numerosa famiglia degli esercenti industrie. Esso non solo da indirizzo al braccio dell ‘uomo, ma ne ravviva la forza visiva, e più che una guida da all’operaio luce d’intelletto, ponendolo in grado dì meditare e cogliere in atto la vis naturae, per farne pratica ed utile applicazione ai bisogni della vita; nel che sta proprio il substratum delle discipline tecniche».
II cav. Lacci concludeva le sue considerazioni sostenendo che se uomini illustri come Giuseppe Rosati ed altri avevano reso grande la città con il loro intelletto, con l’apertura del nuovo Istituto Tecnico altri giovani si sarebbero distinti grazie all’insegnamento tratto dalle nuove materie.
Intanto, il Ministero detta Pubblica Istruzione in una nota inviata al Prefetto comunicava che avrebbe concorso economicamente ed amministrativamente all’apertura dell’Istituto in questione previa ispezione dei locali messi a disposizione Fatte tutte le considerazione del caso il Consiglio Provinciale nella tornata di ottobre 1885 stabilì che L’Istituto Tecnico avrebbe avuto vita a partire dall’anno scolastico 1885/86, che sarebbe stato sotto l’aspetto amministrativo di tipo Governativo a patto che il Comune e la Provincia con propri stanziamenti avessero contribuito alle spese di primo impianto per il periodo suddetto.
Intanto, il Ministero della Pubblica Istruzione in una nota inviata al Prefetto comunicava che avrebbe concorso economicamente ed amministrativamente all’apertura dell’Istituto in questione previa ispezione dei locali messi a disposizione dal Municipio per accertare che gli stessi fossero idonei alle esigenze della scuola.
Ispezionati i locali dell’Annunziata, essi si prestavano solo momentaneamente alle esigenze della scuola stessa che li avrebbe occupati per una durata massima di due anni, fino a quando il Municipio a proprie spese non avesse provveduto a costruire un altro stabile. Così, iI Ministro detta Pubblica Istruzione, on. Coppino, chiese al Parlamento di stanziare la somma necessaria per l’apertura dell’Istituto Tecnico e con Dispaccio del 20 marzo 1885 interrogò gli enti preposti sulle loro intenzioni.
A tale riguardo il Cav. Antonio Cicella, rispose che la Deputazione Provinciale aveva già deliberato favorevolmente affinché entro l’anno scolastico 1885/86 l’Istituto avesse vita e per l’intitolazione della scuola aggiunse:
«[…] si delibera che nella nostra Provincia il più grande cittadino che siasi rivelato fin dal secolo XVII è lo storico Pietro Giannone nato in Ischitella, Comune del Gargano[…]».
Pertanto aveva proposto che l’Istituto fosse intitolato a P. Giannone; la proposta stessa fu approvata con voto unanime. In quella tornata fu stabilito che fosse fornito un elenco di aspiranti insegnanti da proporre su istanza degli stessi al Ministro della Pubblica Istruzione che con Dispaccio del 18 maggio 1885 deliberò favorevolmente circa l’apertura della scuola.
Intanto il 23 maggio 1885, l’ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Provinciale A. Pinto e l’ingegnere Municipale Achille Petti redassero una relazione tecnica sullo stato dei locali dell’Annunziata e, dopo essersi recati ad ispezionare l’Istituto Tecnico di Bari ed aver dialogato con il Preside della scuola, dedussero che varie ragioni impedivano che la scuola foggiana fosse allogata presso l’Annunziata, adducendo la motivazione che occorreva che la scuola avesse un’estensione complessiva di 2600 mq., con ampi locali per i laboratori di chimica e di fisica nonché per la biblioteca scolastica, la sala dei docenti, l’Aula Magna ecc. L’edificio dell’Annunziata si estendeva su una superficie complessiva di mq. 1650 e, pertanto, era inidoneo allo scopo poiché mancava il primo dei requisiti: l’ampiezza.
La seconda motivazione fu riscontrata nella disposizione del fabbricato, anche se fossero stati eseguiti lavori di ripristino dei locali, fra demolizione dei tramezzi e consolidamento della struttura non si sarebbe raggiunto lo scopo, oltre alla spesa eccessiva che il Comune avrebbe dovuto sostenere; il parere dei tecnici dunque, non lasciava speranze al riguardo.
Il 18 settembre 1885, il Ministro Coppino inviò una lettera al Prefetto ed al Presidente della Deputazione Provinciale con cui riproponeva la disponibilità del Ministero a farsi carico dello stanziamento delle somme occorrenti per l’apertura della scuola, pur essendo venuto a conoscenza che i locali scelti e messi a disposizione dal Municipio in realtà non si prestavano allo scopo; tuttavia, se solo ci fosse stata la garanzia che per i primi due anni la scuola, in ogni caso, fosse stata aperta e, soprattutto, se il Comune avesse dato la piena disponibilità alla costruzione di un nuovo edificio il Ministro avrebbe appoggiato la richiesta.
Cosi il 5 ottobre 1885 il Prefetto convocò il Sindaco affinché sentito il Consiglio Comunale si deliberasse favorevolmente in merito alla richiesta ma, il 15 ottobre questi rispose dichiarando che i locali dell’Annunziata erano già pronti per accogliere la scuola facendo anche rilevare che il Comune già aveva dovuto far fronte ad ingenti spese per i lavori di ripristino; assicurò, comunque, che entro il biennio successivo si sarebbe impegnato per garantire la costruzione di un altro edificio.
Stabilita definitivamente l’apertura, l’incarico di Preside del Regio Istituto “P. Giannone”, fu affidato al prof. Vincenzo Nigri, con uno stipendio annuo di L. 300, a lui fu assegnata anche la cattedra di Agronomia e Fisica. Nel 1888/89 fu istituita la biblioteca scolastica e la direzione fu affidata al prof. Giovanni Martinelli, insegnante di Storia Naturale, con uno stipendio di L. 150 annue.
Dopo l’apertura dell’Istituto, ogni anno il Presidente della Giunta di Vigilanza della scuola inviava al Prefetto e al Presidente della Deputazione Provinciale una relazione redatta dal Preside dell’Istituto sull’andamento dell’anno scolastico; quella del 1887-88 redatta dal Preside Prof. Narciso Mencarelli riportava:
«[…] è un esame che mi riempie di soddisfazioni perché nulla può tornare tanto gradito a me vecchio insegnante quanto il dovere lodare l’opera di coloro che mi sono compagni nell’alta missione di ammaestrare la gioventù nei principi del vero, […] la massima parte degli insegnanti di questo Istituto attesero amorosamente dal principio alla fine dell’anno al compimento dei loro doveri scolastici. Ed è con animo riconoscente che io rivolgo loro una parola di lode e d’incoraggiamento per non avermi mai costretto al compimento di uffici che mi sarebbero tornati sempre duri e spiacevoli.[…]».
La relazione si concludeva con l’auspicio che nell’Istituto potesse essere installato un nuovo impianto di azienda rurale che sarebbe sorto accanto alla sezione di agraria.
Negli anni successivi la situazione rimase pressoché invariata anche se più volte i Presidi succeduti avevano inoltrato agli organi preposti le richieste per avere un nuovo edificio. A tale riguardo il Preside Prof. Michele Coppola nella relazione del 1890 sollecitava il Ministero della Pubblica Istruzione affinché l’Istituto potesse avere un’altra sede scrivendo:
«[…] L’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto già mantenere i suoi impegni assunti col Governo, quando l’Istituto fu dichiarato Regio col provvedere in modo conveniente a quanto più volte si è richiesto. Ma credo fuor di proposito di ricordare che l’Istituto Tecnico per il lustro e decoro, onde riesce alla città dovrebbe essere tenuto in maggior considerazione.[…]».
Nel 1886 all’Istituto furono donati dieci ettari di terreno adiacente all’orto botanico affinché il prof. Antonio Lo Re potesse proseguire le sue sperimentazioni cerealicole per perseguire gli obiettivi volti al miglioramento delle colture della Capitanata; in quello stesso anno fu deciso di donare altro terreno per la sezione di Agronomia con la facoltà di decidere sull’istituzione della cattedra di Patologia Vegetale, il cui insegnante sarebbe stato retribuito dalla Provincia.
Oltre all’illustre prof. Vincenzo Nigri, parteciparono alla vita attiva dell’Istituto valentissimi docenti tra cui spiccano i nomi di: Antonio Lo Re, titolare della cattedra di Agraria ed Estimo, ricoprì l’incarico di Preside facente funzioni per quattro volte, fu autore di numerosi volumi sull’agricoltura della Capitanata e, più volte, fu insignito di onorificenze, tra queste: il 26 febbraio 1914 gli fu conferita la medaglia d’argento da S.E. il Ministro della Pubblica Istruzione per l’impegno profuso in occasione della Festa degli Alberi. A ricordo della sua infaticabile opera di educatore gli fu dedicata un’epigrafe che riporta la seguente iscrizione:
| ANTONIO LO RE |
| DAL PRIMO SORGERE DELL ‘ISTITUTO TECNICO DI FOGGIA |
| IN XXXII ANNI D’ININTERROTTO MAGISTERO |
| LA CATTEDRA DI AGRARIA E D ‘ESTIMO |
| ONORO ‘ CON LA PAROLA E CON GLI SCRITTI |
| PRECIPUAMENTE ILLUSTRANDO TESORI E BISOGNI |
| DELLA CAPITANATA DILETTA |
| LE AMMINISTRAZIONI DELLA PROVINCI A E DEL COMUNE |
| MCMXX |
Domenico Santoro, valente Preside, ricoprì tale incarico dal 1° ottobre 1912 al 30 settembre 1922, commissionò il busto di bronzo di P. Giannone e il 22 giugno 1913, in occasione della cerimonia inaugurale del monumento, pronunciò il suo discorso precedendo il Prof. Umberto Tria.
Carlo Palmeri, Preside, pittore e uomo di grandissima cultura. Nel 1965 ricoprì la carica di Presidente dell’Ente Nazionale Protezione Animali. Fu precursore dei suoi tempi richiamando l’attenzione degli studenti su argomenti fino allora mai affrontati, tra questi: introdusse l’ascolto della musica classica sia nell’ora di entrata nelle classi, sia durante la ricreazione;fece in modo che una parte dell’edificio della sezione staccata dell’Istituto fosse adibita ad asilo nido per i figli dei docenti; aderì a qualsiasi iniziativa che rivestisse carattere culturale facendo partecipi sia gli studenti sia gli insegnanti.
Nel 1956, nell’Istituto fuistituita una sezione sperimentale per l’allevamento dei bachi da seta; l’iniziativa era stata lanciata dall’Ente Nazionale Serico di Milano, d’intesa con l’Istituto Agrario di Capitanata, eccellenti furono i risultati, tanto che il 18 giugno 1956 la scuola fu premiata con il Diploma di Merito.
In quello stesso anno alcuni studenti si iscrissero al Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani prendendo parte alle spedizioni organizzate dal gruppo scout foggiano.
Successivamente, gli studenti presero parte al corso di Cultura Aeronautica organizzato dal Ministero della Difesa, il corso si svolgeva durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive ed aveva una durata massima di 6 giorni con due tipi di attività: la prima rivolta agli studenti delle ultime classi, il programma comprendeva anche le prove di volo ecc.; l’altra era rivolta ai ragazzi delle città prive di strutture aeroportuali; i partecipanti migliori furono premiati con pubblicazioni sull’aeronautica.
Nel 1961, con un gruppo di studenti universitari ex alunni, professori e studenti frequentanti l’Istituto, il Preside Palmeri fondò 1′ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI CULTURA con sede a Foggia che aveva come voce ufficiale ai sensi dell’ Art. 1 bis del proprio Statuto Sociale la Rassegna trimestrale «HESTIA», edita dalla tipografia S. Cuore di S. Agata di Puglia, di cui fu direttore responsabile.
La Rassegna aveva un formato di cm. 21×31 e, sulla copertina di ogni numero il titolo era preceduto dalla citazione evangelica: «Amiamoci gli uni gli altri», mentre in basso al centro un’altra citazione recitava: «Noi siamo guidati dalle luci che illuminano e non dalle torce che incendiano; vogliamo costruire, non distruggere…».
Nel primo comitato di redazione furono annoverati i seguenti illustri docenti: Giorgio Banfo, Pompeo Bucci, Saverio Buffa, Ivo Beni, Salvatore Maria Briguccia, Rosa Caracciolo, Vincenzo Coresi, Giulia Di Leo Catalano, Angelo de’ Baroni di Gosta, Giuseppe Fabiano, Reno Fedi, Carlo Gentile, Pietro Giuseppe Lovato, Michelangelo Meola, Grazio Mandelli, Savino Melillo, Michele Notarangelo, Orazio Notarangelo, Enrico Pappacena, Guido Pepe, Donato Piantanida, Carmen Prencipe Di Donna, Vittorio Salvatori.
Nel terzo anno di vita della rivista i docenti Antonio Mandelli e Savino Melillo furono sostituiti da Fausta Nigri e Luigi Treggiari. L’impronta a carattere altamente scientifico e culturale proponeva vari argomenti che spaziavano dalla letteratura alla storia, dall’arte alle scienze, dall’esoterismo alla filosofia, dallo sport all’attualità; tutti gli articoli pubblicati erano d’interesse nazionale, l’editoriale a firma del direttore responsabile, solitamente trattava argomenti informativi inerenti alle ultime leggi scolastiche ed, a volte, erano pubblicati i testi delle circolari ministeriali con i programmi degli Istituti Tecnici. Spesso, quando gli argomenti assumevano importanza internazionale, erano pubblicati in quattro lingue: Francese, Inglese, Tedesco e Spagnolo.
Sul primo numero del 2° anno di vita della rivista, il Preside Carlo Palmeri pubblicò due tavole fuori testo rappresentanti due delle sue opere dal titolo: Luci ed Ombre tav. XXXVI, ed Aurora a S. Lucia tav. XXXVIII.
Sul secondo numero dello stesso anno, egli pubblicò altre due tavole fuori testo raffiguranti altre sue opere dal titolo: Autunno tav. IV e Primavera tav. V, inoltre in questa occasione eccezionalmente fu pubblicato un dipinto della figlia Annalaura dal titolo Bambina tav. VI.
Sempre su questo numero, apparve la prestigiosa firma del noto endocrinologo romano Nicola Pende che disquisiva sull’argomento dal titolo: La Psicologia differenziale dei popoli e le fasi psicologiche ritmiche della storia umana.
Sul quarto numero della rivista relativa allo stesso anno, egli pubblicava altre tavole rappresentanti le sue opere dal titolo: Muta serenità tav. XI e Solstizio d’inverno tav. X.
Probabilmente anche su altri numeri successivi egli continuò ad inserire ed a divulgare le sue opere.
Nell’editoriale del primo numero del 1964, quarto anno della rivista, il Preside Palmeri dopo aver dissertato sull’argomento dal titolo: Gli Istituti Statali di Istruzione Tecnica, salviamo la scuola dalla peste politica, parlando del poco impegno profuso dall’Amministrazione Provinciale di Foggia, accennava alle continue richieste che da tempo immemorabile aveva inoltrato all’Ente affinché provvedesse a far pavimentare il cortile della sezione staccata della scuola che aveva sede in P.zza Cavour, affinché potessero svolgersi gli allenamenti della squadra di “Pallacanestro”, ma fino allora l’Ente non aveva provveduto ad evadere la richiesta; tuttavia il fiore all’occhiello dell’Istituto era la squadra di Atletica Leggera; l’articolo proseguiva:
«[…] La proposta è stata fatta il 26 novembre 1961 l’assessore alla P.I. è andato un paio di volte a visitare il locale seguito dal segretario che prendeva appunti, da ingegneri e da geometri che prendevano le misure e facevano calcoli ma,.., ancora oggi non è stato fatto nulla. […] Anche la richiesta di istituire un gabinetto igienico per gli insegnanti e uno per le insegnanti e un altro per le alunne nella suddetta sezione staccata, le cui aule sono distribuite in tre piani è rimasta inascoltata. E ‘ venuto il solito assessore, il solito segretario che prendeva note nel suo taccuino, i soliti ingegneri e geometri, che hanno preso le misure e fatto disegni… ma, ancora oggi, se un professore… ha bisogno… deve correre al “diurno”… che sì trova in “villa” di fronte al Tribunale […]».
Rilevava inoltre, che per i laboratori di chimica e di merceologia occorreva una bidella, che per le cinque cattedre complete relative alle materie tecnico-pratiche esisteva un solo insegnante specializzato e che il tutto era rimasto fermo all’epoca dell’esistenza di un solo corso.
Fin dal 1962 egli aveva inoltrato la richiesta con la quale proponeva come soluzione alternativa, l’inserimento di alcuni giovani di «[…] eccezionale valore, diplomarsi nello stesso Istituto con votazioni meritevoli di ogni elogio[…]» e, non avendo ancora ricevuto una risposta, aggiungeva: «[…] Nella odierna ingarbugliata vita politica della nostra Patria, non è il merito che si cerca, ma… le ragioni politiche! […]». L’articolo si concludeva con l’invito da parte dei Professori e dello stesso Preside che, riunitisi il 18 febbraio 1964, dopo aver constatato l’inadempienza della Giunta Provinciale, chiedevano alle autorità superiori di intervenire in tal senso affinché con i loro provvedimenti rendessero più funzionali gli Istituti Tecnici senza che “estranei” potessero interferire con le loro decisioni. L’articolo, datato marzo 1964, era firmato dal Preside dell’Istituto.
Queste notizie offrono al lettore una breve nota su quanto accaduto in passato, sottolineando l’attualità delle problematiche.
Tra i docenti inoltre, è ricordato il prof. Orazio Notrarangelo; egli, come si è visto, faceva parte del comitato di redazione della Rassegna «Hestia», già da giovanissimo si era conquistato gli onori divenendo borsista del “Borromeo” di Pavia presso cui si era laureato; ma, legato com’era alle proprie radici preferì rinunciare alla brillante carriera che aveva cominciato proprio in quella città, per rientrare nella sua adorata “Foggia”.
Nel 1955 entrò a far parte del personale docente dell’Istituto “Giannone” insegnando presso la sezione staccata di Manfredonia; nell’anno successivo rientrò a Foggia dove rimase fino al 1976, quando lasciò l’incarico di docente dell’Istituto stesso, per affrontare un compito ancora più difficile: quello di Preside. Aveva già acquisito una lunga esperienza nel settore perché era stato Vicario per alcuni anni presso l’Istituto, pertanto, non gli fu difficile affrontare il nuovo incarico con l’amore per il suo lavoro, che da sempre lo accompagnava.
Lavorò alacremente per la scuola, prima come docente e poi come Preside dell’Istituto che oggi porta il suo nome, fino a quando un male incurabile lo rapì alla vita.
L’Istituto, inoltre, commemora attraverso alcune lapidi murarie, le gesta di chi con ardore dopo il cav. Cicella ha contribuito con il proprio impegno, alla crescita della scuola: è il caso del Gr. Uff. Emilio Ferrane, Presidente del Consiglio Provinciale e della Giunta di Vigilanza nel 1913, al quale è dedicata la seguente epigrafe:
| EMILIO PERRONE |
| DAL MDCCCXCVAL MCMXVI ANNUALMENTE ACCLAMATO |
| PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI VIGILANZA |
| COL FERVIDO ZELO ESERCITATO NEI PUBBLICI OFFICE |
| OND ‘EBBE PREMIO DELLA DIGNITÀ SENATORIA |
| TUTTA L’ANIMA DI CITTADINO |
| DIE ‘ AL LUSTRO ALL ‘INCREMENTO DELL ‘ISTITUTO |
| *** |
| LE AMMINISTRAZIONI DELLA PROVINCIA E DEL COMUNE |
| MCMXX |
Al cav. Antonio Cicella, è dedicata l’epigrafe attualmente collocata nell’Aula Magna dell’Istituto a sinistra dell’ingresso, essa riporta la seguente iscrizione:
| IL COMUNE |
| CELEBRANDOSI LA GLORIA DI PIETRO GIANNONE |
| VOLLE RICORDATO IL NOME |
| DI |
| ANTONIO CICELLA |
| PER L’INFATICATO PATRIOTTICO ARDORE DI LUI |
| COL CONCORSO DELL ‘AMM.NE PROVINCIALE |
| *** |
| SORSE QUESTO ISTITUTO |
| *** |
| XXII GIUGNO MCMXII |
Un’altra. collocata sempre nell’Aula Magna a destra dell’ingresso, è dedicata alla memoria del geom. Giuseppe Albanese Ruffo ed è sormontata dal busto in bronzo dell’eroe.
Ogni anno la biblioteca scolastica era arricchita da volumi, ma furono anche tante le donazioni giunte da collezionisti e cultori; a tale riguardo il 1° agosto 1900, il prof. Michelangiolo Fasolo donò all’Istituto una raccolta di minerali provenienti dalla Sardegna, contribuendo così all’arricchimento del materiale scientifico.
L’Istituto rimase nel locali dell’Annunziata fino al 1935, in questi anni furono numerose le celebrazioni: nel 1913 fu inaugurato il busto di Pietro Giannone, opera del prof. Luigi De Luca, docente di scultura presso il Regio Istituto di Belle Arti di Napoli, in quell’occasione il prof. Umberto Tria durante la cerimonia pronunciò l’orazione dal titolo: Il Pensiero del Giannone.
Nel luglio del 1935, il Regio Istituto fu trasferito nei locali del nuovo Palazzo degli Studi, ed allogato in parte del 1° piano e del 2° piano, su una superficie complessiva di 4.100 mq.; i locali erano forniti di luce elettrica, acqua, gas ecc. molto spaziosi erano anche i laboratori di chimica, fisica e scienze naturali; la Provincia avrebbe pagato al Comune una pigione di L. 68.000 annue, con l’intervento del Prefetto; i vecchi locali sarebbero stati destinati ai PP. Giuseppini per la nuova sistemazione dell’Orfanotrofio M. Cristina, poiché la vecchia sede doveva essere demolita per lasciar spazio alla nuova costruzione del Palazzo degli Uffici Statali.
L’Amministrazione Provinciale provvide alle spese di trasferimento della scuola sostenendo una spesa complessiva di L. 25.000, stipulando un contratto a trattativa privata per l’esecuzione dei lavori di riparazione dei mobili esistenti nei locali dell’Istituto e per il trasporto degli stessi, dai locali dell’Annunziata a quelli di C.so Roma.
L’Istituto ebbe sede nel Palazzo degli Studi fino al secondo conflitto mondiale: dal ’43 al ’45 il Palazzo degli Studi fu occupato dalle truppe anglo-americane e l’Istituto ebbe come sede provvisoria alcuni locali nel Palazzo Dogana. Ritornò presso il Palazzo degli Studi quando gli americani lasciarono la città.
A Foggia vi era un secondo Istituto Tecnico intitolato a “F. Crispi” ad indirizzo mercantile, sorto nel 1928, reso Regio il 16 ottobre 1937 che con R.D. n. 711 dell’ 11 gennaio 1943 ebbe il riconoscimento giuridico e l’autonomia con l’approvazione dello statuto; mentre il “Giannone” aveva l’indirizzo amministrativo.
Nel 1945, il “Giannone” fu soppresso e fuso con il “Crispi”, in quell’occasione il Provveditore agli studi prof. Ioanna, comunicò ai Presidi dei due Istituti che il Ministero della P. I. con nota n. 6709 del 10/10/1945 aveva stabilito la soppressione del “Giannone” in quanto l’esistenza di due scuole simili nella città era superflua. Pertanto, a decorrere dal 1° ottobre di quell’anno era stata istituita una sezione per geometri presso l’Istituto “Crispi” che assumeva la seguente denominazione: “Regio Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo Mercantile e per Geometri Crispi”. La cosa però non piacque né alla cittadinanza, né alle amministrazioni locali, né ai docenti del “Giannone”, i quali il 20 ottobre di quell’anno, si riunirono in seduta straordinaria per inviare una petizione al Ministero della P. I., affinché fosse rivista la decisione di sopprimere l’Istituto adducendo la seguente motivazione:
«[…] l’Istituto è fra i più antichi dell’Italia meridionale, culla di valenti professionisti di cui non pochi hanno onorato la Provincia conseguendo altissimi gradi specie nell’Amministrazione Statale e nelle Forze Armate […]».
In quell’occasione furono ricordati i nomi dei “Grandi” che avevano caldeggiato per l’apertura della scuola, e che se fossero stati ancora in vita avrebbero fatto in modo che la scuola non fosse stata chiusa.
Nel successivo verbale del 30 ottobre di quello stesso anno, il personale docente, pur non arrendendosi, chiedeva che fosse almeno mantenuto il nome del “Giannone”, anche se, per motivi burocratici il “Crispi” non poteva essere soppresso.
In quel periodo gli organi della stampa locale e nazionale si interessarono al caso, tanto da pubblicare numerosi articoli riguardanti la chiusura dell’Istituto.
Ma non fu solo la stampa ad occuparsi di ciò che stava accadendo a Foggia, le proteste infatti, giunsero fino al Ministero.
Il Provveditore agli studi intanto, cercò di spiegare le motivazioni che avevano indotto il Ministero stesso a sopprimere l’Istituto Tecnico più antico della città: la ragione principale riguardava un provvedimento di riduzione della spesa pubblica con la soppressione del numero di Istituti Tecnici Commerciali risultati superflui nel paese; ma le motivazioni espresse dal Provveditore non furono ritenute esaustive, infatti né la cittadinanza né i docenti accettarono che la scuola fosse soppressa, inoltre, essendo il “Crispi” più recente, ed avendo natura giuridica simile a quella del “Giannone”, ritenevano che si potesse eliminare quest’ultimo.
Nonostante le proteste, l’Istituto fu definitivamente chiuso, e l’8 novembre 1945 fu stabilita la fusione dei due Istituti.
Le manifestazioni di protesta mosse contro la chiusura della scuola continuarono ad oltranza, fino a quando il Ministero non revocò la proposta di soppressione del primo Istituto; anche in questo caso la stampa si occupò della questione.
Più tardi l’Istituto, fu riaperto ed il “Crispi” fu definitivamente assorbito dal “Giannone” che assunse l’indirizzo mercantile con la sezione per geometri.
Finalmente dopo tanto fermento la città aveva riavuto ciò che le apparteneva di diritto e che a causa dell’ingiusta burocrazia del paese le era stato tolto… !
II 1° ottobre 1960 la sezione per Geometri si separò dando vita all’Istituto “E. Masi”, ed il 1° ottobre 1969 per l’elevato numero di studenti l’Istituto “Giannone” si scisse e fu fondato il “Rosati” ad indirizzo amministrativo.
Nel 1971 l’Istituto “P. Giannone” fu definitivamente trasferito in Via Sbano, attuale sede, costruita dall’Amministrazione Provinciale con la vendita dell’immobile della caserma dei Carabinieri che già in passato aveva ospitato alcune classi della sezione staccata dell’Istituto.
La scuola ha mantenuto l’indirizzo Mercantile fino all’anno 1999 infine, grazie all’impegno dell’attuale Dirigente Scolastico, prof. Alfonso Palomba e dei Suoi collaboratori, per proseguire nuovi traguardi ed adeguarsi alle prospettive europee, ha allargato i propri orizzonti assumendo nuovi indirizzi: quello IGEA dal 1996/97 diventato definitivo dal 2000, quello per Programmatori ed infine, quello Turistico-Iter dall’a. s. 2000/2001.
©2005 Lucia Lopriore. Il presente contributo è stato tratto dal saggio dell’Autrice dal titolo: L’ITC “P. Giannone” di Foggia dalle origini ad oggi, in G. CRISTINO, L. LOPRIORE, V. MARCHESIELLO, L’ITC “P. Giannone” di Foggia e la sua Galleria d’Arte, a cura di A. M. Palomba, Foggia 2002.